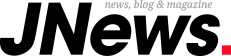Il fenomeno dell’isola di calore si manifesta nelle aree urbane, dove la presenza di edifici ad alta densità e la scarsa vegetazione determinano una maggiore intensità di calore rispetto alle zone con laghi, fiumi e alberi. La gravità del fenomeno varia a seconda delle condizioni atmosferiche, delle stagioni e delle ore del giorno. Negli ultimi anni, l’interesse per gli effetti del cambiamento climatico e la ricerca di strategie per l’adattamento e la mitigazione hanno portato a un aumento degli studi sulle caratteristiche, le cause e gli impatti delle isole di calore.
Le isole di calore sono presenti in qualsiasi agglomerato urbano, ma sono maggiormente studiate nelle grandi città con una popolazione superiore a un milione di abitanti. Attualmente, più della metà della popolazione mondiale vive in città, e in Italia, il 70% della popolazione vive in agglomerati urbani. I comuni stanno cercando di trovare un equilibrio tra superfici vegetate e impermeabili, poiché la quantità di questi elementi influenza la composizione del paesaggio urbano e modifica il microclima favorendo la formazione di isole di calore.
Per studiare le isole di calore, vengono utilizzate mappe che evidenziano le differenze di temperatura tra le aree urbane e le zone rurali circostanti. Le centraline meteo misurano la temperatura dell’aria, ma non coprono tutti i quartieri, mentre le immagini termiche satellitari consentono di osservare tutto il territorio senza interruzioni. Queste immagini, tuttavia, presentano limiti come la risoluzione spaziale e la periodicità dei passaggi dei satelliti. Nonostante ciò, le immagini termiche satellitari sono uno strumento prezioso per identificare le aree più suscettibili di diventare isole di calore.
Le isole di calore si manifestano anche durante la notte, quando le zone urbane conservano il calore accumulato durante il giorno, aumentando il disagio termico. In molte situazioni, la differenza di temperatura tra le aree urbane e quelle.